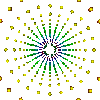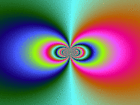Comportamento, apprendimento, memoria, coscienza, dolore. Queste parole di solito si riferiscono al mondo animale. Oggi però gli esperti di neurobiologia vegetale le usano per studiare e definire le piante. Ma queste facoltà possono esistere senza un cervello? Il dibattito scientifico è molto acceso.
Nel 1973 un libro in cui si sosteneva che le piante sono esseri senzienti, provano emozioni, preferiscono la musica classica al rock e possono reagire ai pensieri inespressi degli esseri umani anche a centinaia di chilometri di distanza entrò nella classifica del New York Times dei saggi più venduti. La vita segreta delle piante di Peter Tompkins e Christoper Bird ( Il Saggiatore 2009 ) era un’affascinante miscela di studi scientifici, esperimenti un po’ improvvisati e venerazione mistica per la natura che catturò la fantasia dei lettori in un’ epoca in cui cominciava a diffondersi la cultura new age. Le pagine più memorabili sono quelle che descrivono gli esperimenti di un ex tecnico delle macchine della verità della Cia, Cleve Backster. Nel 1966 Backster aveva avuto la bizzarra idea di collegare un galvanometro ( uno strumento che misura le correnti elettriche ) a una foglia di dracena, la pianta che aveva nel suo studio. Con sua grande sorpresa, aveva scoperto che gli bastava immaginare che la dracena prendesse fuoco perché l’ago del poligrafo salisse, registrando un aumento dell’attività elettrica che indicava una condizione di stress. “ Era possibile che la pianta gli leggesse nel pensiero ? “, si chiedevano gli autori della Vita segreta delle piante. Backster aveva voglia di correre in strada e gridare al mondo “ Le piante pensano ! “. Backster aveva continuato a collegare i poligrafi a decine di piante, cespi di lattuga, cipolle, arance e banane. Sosteneva che le piante reagivano ai pensieri degli esseri umani vicini a loro. Con quelli con cui avevano più familiarità reagivano anche a grande distanza. In un esperimento per verificare se le piante avessero una memoria, Backster aveva scoperto che una pianta testimone dell’uccisione ( per calpestamento ) di un’altra pianta riusciva a riconoscere l’assassino tra sei sospetti: l’attività elettrica aumentava quando se lo trovava davanti. Le piante di Backster mostravano anche una forte avversione per la violenza tra le specie. Alcune davano segnali di stress quando si rompeva un uovo in loro presenza, o quando una manciata di gamberetti vivi veniva gettata nell’acqua bollente, un esperimento che Backster aveva raccontato sul Journal of Parapsychology nel 1968.
Negli anni successivi alcuni studiosi di botanica cercarono di riprodurre “l’effetto Backster”, ma senza successo. Buona parte delle scoperte riportate nella Vita segreta delle piante sono state smentite. Ma il libro ha lasciato il segno nella nostra cultura. Gli statunitensi hanno cominciato a parlare con le piante e a fargli ascoltare Mozart, e sono sicuro che molti lo fanno ancora. Può sembrare una cosa innocua: probabilmente ci sarà sempre un po’ di romanticismo nel modo in cui pensiamo alle piante. Ma, secondo molti botanici, La vita segreta delle piante ha danneggiato in modo permanente questo settore della ricerca. Secondo Daniel Chamovitz, un biologo israeliano autore di Quel che una pianta sa ( Raffaello Cortina 2013 ), Tompkins e Bird “ hanno impedito ricerche più serie sul comportamento delle piante perché gli scienziati sono diventati diffidenti nei confronti di qualsiasi studio che alludesse a possibili paralleli tra i sensi degli animali e quelli delle piante “. Altri sostengono che La vita segreta delle piante ha provocato una sorta di “ autocensura “ nei ricercatori che avrebbero voluto approfondire “ le possibili omologie tra neurobiologia e fitobiologia “, cioè la possibilità che le piante siano molto più intelligenti e simili a noi di quanto si pensi.
I primi accenni all’autocensura sono apparsi in un articolo del 2006 pubblicato sulla rivista Trends in Plant Science, che proponeva un nuovo campo di ricerca chiamato, forse un po’ imprudentemente, “ neurobiologia vegetale “. I sei autori dell’articolo – tra cui il fitobiologo molecolare statunitense Eric D. Brenner, il fisiologo vegetale italiano Stefano Mancuso, il biologo cellulare slovacco Frantisek Baluska e la fitobiologa statunitense Elisabeth van Volkenburgh – sostenevano che i meccanismi genetici e biochimici che conosciamo non sono in grado di spiegare i sofisticati comportamenti osservati nel mondo vegetale. Le piante sono capaci di sentire e di reagire a così tante variabili ambientali – luce, acqua, gravità, temperatura, struttura del terreno, sostanze nutritive, tossine, microbi, presenza di erbivori, segnali chimici inviati da altre piante – che potrebbero essere dotate di un sistema di elaborazione delle informazioni simile a un cervello, capace di integrare i dati e coordinare la risposta comportamentale. Gli autori osservavano che nelle piante erano stati individuati sistemi di segnali elettrici e chimici simili a quelli presenti nel sistema nervoso degli animali, e neurotrasmettitori come la serotonina, la dopamina e il glutammato, anche se il loro ruolo non era ancora chiaro.
Da qui la necessità di una neurobiologia vegetale, un nuovo settore di ricerca “ volto a comprendere come le piante percepiscono il loro ambiente e come reagiscono ai suoi input in modo integrato “. L’articolo concludeva che le piante mostrano di avere una forma di intelligenza, “ una capacità intrinseca di elaborare informazioni a partire da stimoli biotici e abiotici che gli consente di prendere decisioni ottimali riguardo alle proprie attività future in un dato ambiente “. Qualche tempo prima della pubblicazione di questo articolo, nel 2005, la Society for plant neurobiology aveva organizzato il suo primo convegno a Firenze. E una nuova rivista scientifica, dal nome meno provocatorio di Plant Signaling & Behavior, sarebbe apparsa l’anno successivo.
Arroganza umana
Gli esperti di fitoscienze hanno opinioni diverse sullo studio della neurobiologia vegetale. Secondo alcuni è un paradigma radicalmente nuovo per la comprensione della natura, per altri un ritorno alle tesi poco scientifiche della Vita segreta delle piante. I sostenitori della neurobiologia vegetale sono convinti che dobbiamo smettere di considerare le piante come oggetti passivi e cominciare a trattarle come protagonisti attivi, molto abili nel gareggiare tra loro in natura, Contestano l’interesse riduttivo della biologia contemporanea per le cellule e i geni e vorrebbero rimettere al centro dell’attenzione gli organismi e i loro comportamenti nell’ambiente. E’ solo l’arroganza umana, unita al fatto che la vita delle piante si svolge in una dimensione temporale molto più lenta, a impedirci di comprendere la loro intelligenza e la loro conseguente diffusione. Le piante dominano in tutti gli ambienti terrestri e rappresentano il 99 per cento della biomassa del pianeta. In confronto, gli esseri umani e tutti gli altri animali sono, per usare le parole di un fitoneurobiologo, “ solo tracce “.
Molti botanici si oppongono alla nascita di questo nuovo campo di ricerca. Primi tra tutti i 36 eminenti studiosi ( Amedeo Alpi e altri ) che, in risposta al manifesto di Brenner, hanno scritto una sarcastica lettera pubblicata su Trends in Plant Science. “ Cominceremo con il dire semplicemente che nelle piante non abbiamo le prove dell’esistenza di strutture simili a neuroni e sinapsi né di un cervello “, hanno scritto. In realtà, nessuno ha mai fatto un’affermazione del genere, nel manifesto si parla solo di strutture “ omologhe “. Ma l’uso della parola 2 neurobiologia “ in mancanza di veri e propri neuroni era più di quanto molti scienziati potessero sopportare.
Il problema tocca la linea di confine tra il regno animale e quello vegetale
“ E’ vero, le piante inviano segnali elettrici sia a breve sia a lungo termine, e usano come segnali chimici alcune sostanze simili ai neurotrasmettitori “, mi ha detto Lincoln Taiz, un professore emerito di fitofisiologia dell’università della California a Santa Cruz, che è stato tra i firmatari della lettera di Alpi. “ Ma i meccanismi sono piuttosto diversi da quelli dei sistemi nervosi “. Secondo Taiz, i neurobiologi vegetali “ danno un’interpretazione forzata dei dati, sono teleologici, antropomorfizzano, filosofeggiano e fanno ipotesi azzardate “. Taiz è sicuro che prima o poi i comportamenti delle piante che non siamo ancora in grado di comprendere troveranno una spiegazione nei circuiti chimici ed elettrici, senza dover ricorrere a nessun tipo di “ animismo “. Clifford Slayman, docente di fisiologia cellulare e molecolare a Yale, anche lui tra i firmatari della lettera di Alpi, è stato ancora più brusco. “ L’idea di un’intelligenza delle piante è una stupida divagazione, non un nuovo paradigma “, mi ha scritto recentemente in un’email. Slayman definisce la lettera di Alpi “ l’ultimo confronto serio su questo tema tra la comunità scientifica e un branco di squilibrati “. E’ raro che gli scienziati parlino così dei loro colleghi con un giornalista, ma il problema è molto sentito, forse perché tocca la linea di confine tra il regno animale e quello vegetale. La polemica non è tanto sulle ultime scoperte delle fitoscienze, quanto su come dovrebbero essere interpretate ed etichettate: certi comportamenti delle piante che somigliano molto all’apprendimento, alla memoria, alla capacità di prendere decisioni e all’intelligenza meritano di essere definiti con questi termini? O queste parole dovrebbero essere usate solo per gli esseri dotati di un cervello?
Nessuno degli studiosi dell’intelligenza delle piante sostiene che le piante hanno poteri telecinetici o che provano emozioni. E nessuno pensa che nelle piante prima o poi troveremo un organo a forma di noce che elabora i dati sensoriali e dirige il loro comportamento. Secondo gli scienziati, è più probabile che l’intelligenza delle piante somigli a quella delle colonie di insetti, sia cioè una facoltà che emerge in una massa di individui organizzati in una rete. Buona parte delle ricerche sull’intelligenza delle piante è stata ispirata dalla nuova scienza delle reti, dal calcolo distribuito e dal comportamento degli stormi, che dimostrano l’esistenza di comportamenti intelligenti anche in assenza di un cervello. “ Per una pianta, avere un cervello non è un vantaggio “, dice Stefano Mancuso, del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale di Firenze.
Secondo Mancuso, la nostra “ feticizzazione “ dei neuroni e la nostra tendenza a identificare il comportamento con la mobilità ci impediscono di capire quello che le piante sono in grado di fare. Per esempio, dato che non possono scappare e spesso vengono mangiate, le piante non hanno nessun organo insostituibile. “ hanno una struttura modulare che gli consente di perdere fino al 90 per cento del loro corpo senza morire “, spiega. “ Nel mondo animale non esiste niente del genere. Questo le rende più flessibili “.
In effetti, molte delle capacità delle piante che ci colpiscono di più sono legate alla loro condizione esistenziale di esseri radicati nel terreno e quindi incapaci di spostarsi quando hanno bisogno di qualcosa o quando le condizioni di vita diventano sfavorevoli. Lo “ stile di vita sessile “, come lo chiamano i botanici, richiede una comprensione ampia e dettagliata dell’ambiente immediatamente circostante, perché la pianta deve poter trovare quello di cui ha bisogno, e potersi difendere, pur rimanendo sempre nello stesso posto. Ha bisogno di un apparato sensoriale estremamente sviluppato per localizzare il nutrimento e accorgersi dei pericoli. Le piante hanno sviluppato tra i quindici e venti sensi diversi, compresi i cinque simili ai nostri: odorato e gusto ( sentono e reagiscono alle sostanze chimiche presenti nell’aria o sul loro corpo ); vista ( reagiscono in modo diverso a varie lunghezze d’onda della luce e all’ombra ); tatto ( una pianta rampicante o una radice “sanno” quando incontrano un oggetto solido ), e a quanto sembra, anche l’udito. In un recente esperimento Heidi Appel, una chemioecologa dell’università del Missouri, ha scoperto che se faceva ascoltare a una pianta la registrazione di un bruco che masticava una foglia, quel suono bastava per mettere in moto il suo meccanismo genetico per la produzione di difese chimiche.
Alcuni scienziati hanno anche scoperto che la punta delle radici delle piante, oltre a sentire la gravità, l’umidità, la luce, la pressione e la durezza, percepisce anche il volume, la presenza di azoto, fosforo, sale, varie tossine, microbi e i segnali chimici inviati dalle piante vicine. Quando si accorgono che stanno per incontrare un ostacolo insuperabile o una sostanza tossica, le radici cambiano strada prima di entrarci in contatto. Sanno se le radici vicine appartengono alla loro pianta o a un’altra e, in quest’ultimo caso, se è della stessa famiglia o no. Di solito contendono lo spazio alle radici di piante estranee, ma quando i ricercatori hanno messo nello stesso vaso quattro piante della stessa famiglia di Cakile edentula dei Grandi Laghi, hanno riscontrato che il loro comportamento era meno competitivo e che le piante tendevano a condividere le risorse.
Segnali d’allarme
In qualche modo, una pianta raccoglie e integra tutte queste informazioni sul suo ambiente e poi “decide” – alcuni scienziati usano le virgolette per sottolineare che è una metafora, altri no – in quale direzione sviluppare le radici o le foglie. Quando la definizione di “comportamento” viene allargata fino a includere cose come il cambiamento di percorso delle radici, la ridistribuzione delle risorse o l’emissione di sostanze chimiche, le piante cominciano a sembrare agenti attivi, che rispondono ai messaggi dell’ambiente in modo più sottile o adattivo di quanto farebbe pensare la parola “istinto”. “Le piante percepiscono la presenza di rivali e se ne allontanano”, mi ha spiegato Rick Karban, un fitoecologo dell’università della California a Davis. “Reagiscono a potenziali concorrenti prima ancora che arrivino a fargli ombra”. Questi sono comportamenti complessi ma, come quasi tutti i comportamenti delle piante, agli occhi degli animali sono invisibili o appaiono molto lenti.
Lo stile di vita sessile spiega anche la straordinaria capacità biochimica delle piante, che è molto maggiore di quella degli animali e, probabilmente, di qualsiasi chimico umano. Non potendo fuggire, le piante usano un complesso vocabolario molecolare per segnalare il loro disagio, scoraggiare o avvelenare i nemici, e spingere gli animali a rendergli vari servizi. Un recente studio pubblicato sulla rivista Science ha dimostrato che la caffeina prodotta da molte piante può essere non solo uno strumento di difesa, ma in alcuni casi può funzionare come una droga, che spinge le api a ricordare una particolare pianta e a tornarci. Uno dei settori più produttivi della ricerca sulle piante degli ultimi anni è stato lo studio dei segnali che inviano. Dall’inizio degli anni ottanta sappiamo che quando sono infestate dagli insetti, le foglie di una pianta emettono sostanze chimiche volatili per segnalare ad altre foglie che devono prepararsi a difendersi. A volte questi segnali contengono informazioni sul tipo di insetto dedotte dal sapore della sua saliva. A seconda della pianta e dell’aggressore, la difesa può consistere nel modificare il sapore della foglia o la sua consistenza, o nel produrre tossine o altri composti chimici che la rendono meno digeribile. Quando le antilopi brucano le foglie di acacia, le foglie producono tannino, che le rende meno appetibili e più difficili da digerire. Quando il cibo è scarso e le acacie sono troppo sfruttate, sembra che producano una quantità di tossina sufficiente a uccidere gli animali. Forse l’esempio più interessante riguarda due specie di insetti, che si comportano gli uni come aggressori, gli altri come difensori. Diverse specie di piante, compreso il mais e il fagiolo di Spagna, quando sono attaccate dai bruchi emettono un segnale chimico di allarme. Le vespe parassite che si trovano nelle vicinanze sentono quell’odore, lo seguono fino a raggiungere la pianta attaccata e cominciano a uccidere i bruchi. Gli scienziati le chiamano “guardie del corpo delle piante”.
Mimose intelligenti
Le piante usano un linguaggio chimico che non possiamo percepire né comprendere direttamente. Le prime scoperte importanti sul loro sistema di comunicazione furono fatte in laboratorio negli anni ottanta, isolando le piante e le loro emissioni chimiche in contenitori di plexiglas, ma Rick Karban, l’ecologo dell’università di Davis, e altri ricercatori si sono assunti un compito difficile: studiare come le piante si scambiano segnali chimici in un ambiente naturale. Sono andato a trovare Karban nel suo laboratorio all’aperto alla Sagehen Creek field station dell’università, a 180 chilometri da Davis. Su un pendio tra le montagne della Sierra Nevada, mi ha mostrato 99 arbusti di artemisia tridentata che lui e i suoi colleghi tengono sotto osservazione da più di dieci anni.
Karban è un newyorchese di 59 anni magro e con una massa di riccioli bianchi. Ha dimostrato che quando all’inizio della primavera le foglie di artemisia vengono spuntate per simulare un attacco e innescare il rilascio di sostanze chimiche volatili, nel corso della stagione sia la pianta spuntata sia le sue vicine intatte sono meno soggette all’attacco degli insetti. Karban è convinto che la pianta avverta le sue foglie della presenza del parassita, e che anche le piante vicine captino il segnale. Ha scoperto anche che più le piante sono imparentate tra loro, più è probabile che rispondano al segnale chimico, e questo fa pensare che siano in grado di riconoscere quelle della stessa famiglia. Un giorno queste ricerche sul modo di comunicare delle piante potrebbero tornare utili agli agricoltori. I segnali d’allarme potrebbero essere usati per innescare i meccanismi di difesa, riducendo l’uso di insetticidi.
Ho conosciuto Karban nel luglio del 2013 a un convegno organizzato a Vancouver. Il convegno doveva essere il sesto della Society for plant neurobiology, ma dietro pressione dell’establishment scientifico il nome dell’associazione era stato cambiato quattro anni prima nel meno provocatorio Society for plant signaling and behavior.
Le metafore stimolano la fantasia degli scienziati e li spingono a indagare
La fitobiologa Elizabeth Van Volkenburgh dell’università di Washington, una delle fondatrici dell’associazione, mi ha raccontato che il nome è stato cambiato dopo un vivace dibattito interno. Qualcuno della National science foundation mi ha detto che la fondazione non avrebbe mai finanziato un’organizzazione il cui nome contenesse le parole “neurobiologia vegetale”: “Secondo loro il prefisso ‘neuro’ si può usare solo per gli animali”. Due dei fondatori dell’associazione, Stefano Mancuso e Frantisek Baluska, si sono opposti al cambiamento e continuano a usare “neurobiologia vegetale” nei loro articoli e nei nomi dei loro laboratori. Il convegno, che si teneva all’università della British Columbia e a cui partecipavano un centinaio di scienziati, consisteva in tre giorni di presentazioni. Per la maggior parte erano discorsi molto tecnici sui sistemi di segnalazione delle piante, come si addice a una scienza che ormai si muove nell’ambito di un paradigma ben consolidato. Ma un piccolo gruppo di persone ha presentato scoperte che sembravano rientrare più nel nuovo paradigma dell’intelligenza delle piante, suscitando forti reazioni. L’intervento più discusso è stato quello intitolato “L’apprendimento della Mimosa pudica”, che partiva da un saggio non ancora pubblicato di Monica Gagliano, un’ecologa animale di 37 anni dell’universtà della Western Australia che stava lavorando nel laboratorio di Mancuso a Firenze. Gagliano aveva basato il suo esperimento su una serie di protocolli normalmente usati per testare l’apprendimento negli animali. Si era concentrata su un tipo di apprendimento elementare detto “per assuefazione”, in cui si insegna a ignorare uno stimolo irrilevante. “L’assuefazione permette a un organismo di concentrarsi sulle informazioni importanti e di filtrare quelle superflue”, ha spiegato Gagliano al pubblico. Di solito gli esperimenti servono a verificare quanto tempo impiega un animale a capire che uno stimolo è “superfluo” e per quanto tempo ricorderà quello che ha imparato. La domanda che lei si era posta era ancora più stimolante. Si può ottenere lo stesso risultato con una pianta?
La mimosa pudica, detta anche “sensitiva”, è una pianta rara il cui comportamento è così rapido e visibile che anche gli animali possono osservarlo. Quando le sue foglie felciformi vengono toccate, si richiudono immediatamente, presumibilmente per spaventare gli insetti. Quando la pianta viene urtata o fatta cadere le foglie si afflosciano. Gagliano aveva piantato in vaso 56 mimose e creato un meccanismo che ne simulava la caduta da un’altezza di 15 centimetri ogni cinque secondi. Ogni “seduta di addestramento” consisteva in sessanta cadute. Nel suo intervento ha raccontato che alcune delle mimose avevano ricominciato ad aprire le foglie dopo quattro, cinque o sei cadute, come se avessero capito che quello stimolo poteva essere tranquillamente ignorato. “Alla fine erano completamente aperte”, ha detto Gagliano. “Non gliene importava più niente”.
Si erano semplicemente stancate? Sembra di no: quando venivano scosse si chiudevano di nuovo. “Ehi, questa è una cosa nuova!”, ha detto Gagliano, mettendosi dal punto di vista delle piante. “Si erano accorte della novità. Poi le abbiamo fatte cadere di nuovo, e non hanno reagito”. Gagliano aveva messo alla prova di nuovo le piante una settimana dopo e aveva verificato che continuavano a ignorare quello stimolo, quindi “ricordavano” quello che avevano appreso. Non l’avevano dimenticato neanche dopo 28 giorni. Gagliano ha ricordato ai colleghi che, facendo lo stesso esperimento, gli insetti dimenticano quello che hanno imparato dopo 48 ore. Ha concluso dicendo che “cervello e neuroni sono una soluzione sofisticata ma non necessaria per imparare”, e che c’è “un qualche meccanismo in tutti i sistemi viventi che può elaborare le informazioni e imparare”.
Il suo intervento ha scatenato una vivace discussione. Qualcuno ha obiettato che per una pianta una caduta non è uno stimolo rilevante perché non lo incontra in natura. Ma Gagliano ha risposto che negli esperimenti con gli animali si usano le scosse elettriche, che sono uno stimolo altrettanto artificiale. Un altro scienziato ha avanzato l’ipotesi che forse le sue piante non si erano assuefatte, ma erano semplicemente sfiancate. Lei ha replicato che 28 giorni sarebbero stati un tempo sufficiente per ricostruire le riserve di energia.
Le parole e le cose
Uscendo dalla sala convegni, mi sono imbattuto in Fred Sack, un noto botanico dell’università della British Columbia, e gli ho chiesto cosa pensava dell’intervento di Gagliano. “Sciocchezze”, ha risposto. Mi ha spiegato che la parola “apprendimento” implica la presenza di un cervello e dovrebbe essere riservata agli animali. “Gli animali apprendono, le piante si adattano”. Ha fatto una distinzione tra le modifiche del comportamento che avvengono nell’arco della vita di un organismo e quelle che si verificano nel corso di generazioni. A pranzo ero seduto accanto a uno scienziato russo altrettanto scettico. “Non è apprendimento”, ha detto. “Non c’è niente di cui discutere”.
Nel pomeriggio Gagliano appariva ferita da alcune delle reazioni al suo intervento, ma era diventata più combattiva. Mi ha detto che l’adattamento è un processo troppo lento per spiegare il comportamento delle piante nel suo esperimento. “Come possono adattarsi a qualcosa che non hanno mai incontrato nel mondo reale?”. Gagliano aveva osservato che alcune delle sue piante imparavano più rapidamente di altre, quindi “non si trattava di un tipo di reazione innata o programmata”. Molti scienziati tra il pubblico si stavano abituando all’idea che le piante hanno un “comportamento” e una “memoria”. Era stato l’uso di parole come “apprendimento” e “intelligenza” che li aveva colpiti perché, per citare Sacks, appariva “strano e inappropriato”.
Gagliano ha detto che il suo studio sulle mimose era stato respinto da dieci riviste specializzate. “Nessuno dei selezionatori aveva messo in discussione i dati”. Erano spaventati dal linguaggio usato per descriverli. Ma lei non intendeva cambiarlo. “Se non usiamo lo stesso linguaggio per descrivere gli stessi comportamenti” nelle piante e negli animali, “non possiamo fare confronti”, ha detto. Dopo il suo intervento, Rick Karban l’ha consolata dicendo: “A me è successa la stessa cosa, mi hanno stroncato. Stiamo facendo un buon lavoro, è il sistema che non è ancora pronto”. Quando gli ho chiesto cosa pensava dello studio di Gagliano, ha risposto: “Non so se i dati sono tutti corretti, ma è un’idea interessante che merita di essere discussa. Spero che non si scoraggi”.
Il poeta filosofo del movimento
A volte gli scienziati si sentono a disagio quando si parla del ruolo delle metafore e della fantasia nel loro lavoro, ma il progresso scientifico spesso dipende da queste due cose. “Le metafore stimolano la fantasia degli scienziati e li spingono a indagare”, ha scritto il botanico inglese Anthony Trewavas nella sua arguta risposta alla lettera di Alpi contro la teoria di una neurobiologia vegetale. “Ovviamente si tratta di una metafora: le piante non possiedono quel tipo di cellule eccitabili e comunicative che chiamiamo neuroni. Ma l’introduzione del termine ha sollevato una serie di interrogativi e ispirato alcuni esperimenti che promettono di aiutarci a comprendere più a fondo non solo le piante ma anche il cervello. Se esistono altri modi di elaborare le informazioni, altri tipi di cellule e di reti cellulari che possono dare origine a comportamenti intelligenti, potremmo arrivare a chiederci, come Mancuso: “Cos’hanno di tanto speciale i neuroni?”.
Mancuso è il poeta-filosofo del movimento, deciso a ottenere per le piante il riconoscimento che meritano e, forse, a far scendere un po’ dal piedistallo gli esseri umani. Nonostante il nome altisonante, il suo Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale è costituito da una serie di uffici e laboratori che occupano un modesto edificio moderno alla periferia di Firenze. Qui un piccolo gruppo di collaboratori e neolaureati svolge gli esperimenti ideati da Mancuso per testare l’intelligenza delle piante. Mentre mi accompagna in giro per i laboratori, mi mostra alcune piante di mais cresciute alla luce artificiale alle quali stanno insegnando a ignorare l’ombra; un piccolo pioppo che hanno collegato a un galvanometro per misurare come reagisce all’inquinamento; e una stanza in cui una macchina Ptr-Tof – un tipo avanzato di spettrometro di massa – legge continuamente tutte le sostanze volatili emesse da una serie di piante, dai pioppi ai peperoni agli olivi.
“Stiamo costruendo un dizionario per ogni specie, un intero vocabolario chimico”, mi spiega. Secondo Mancuso nel vocabolario di una pianta ci sono circa tremila sostanze chimiche, mentre, dice sorridendo, “quello di uno studente medio è fatto solo di settecento parole”. All’inizio della nostra conversazione, ho chiesto a Mancuso di darmi una definizione di “intelligenza”. Dopo aver passato tanto tempo coni neurobiologi vegetali, non sono più sicuro di cosa voglia dire quella parola. E, a quanto sembra, non sono il solo. Filosofi e psicologi discutono da almeno un secolo sulla definizione di intelligenza, e quel poco consenso che forse esisteva un tempo ormai non c’è quasi più. La maggior parte delle definizioni di intelligenza rientrano in due categorie. La prima richiede la presenza di un cervello, e fa riferimento a qualità mentali intrinseche come la ragione, il giudizio e il pensiero astratto. La seconda, che è meno metafisica e legata al cervello e più al comportamento, definisce l’intelligenza in termini di capacità di reagire in modo ottimale alle sfide dell’ambiente e alle diverse situazioni. Come era prevedibile, i neurobiologi vegetali preferiscono la seconda.
Forse la parola più inquietante che si possa applicare alle piante è “coscienza”
“la mia definizione è molto semplice”, ha detto Mancuso. “l’intelligenza è la capacità di risolvere problemi”. Piuttosto che un cervello, “cerco una sorta di intelligenza distribuita, come quella degli stormi di uccelli”. In uno stormo, ogni uccello deve rispettare poche semplici regole, come mantenere la distanza prescritta dal suo vicino, ma il risultato collettivo di molti uccelli che eseguono un semplice algoritmo è un comportamento complesso e superbamente coordinato. L’ipotesi di Mancuso è che esista qualcosa di simile anche nelle piante, con le loro migliaia di radici che svolgono il ruolo dei singoli uccelli, raccogliendo dati dall’ambiente, valutandoli e reagendo in un modo localizzato ma coordinato che va a vantaggio dell’intero organismo.
“Forse diamo troppa importanza ai neuroni”, ha detto. “In fondo sono solo cellule eccitabili”. Anche le piante hanno le loro cellule eccitabili, molte delle quali si trovano proprio dietro la punta delle radici. Lì, Mancuso e il suo collega Frantisek Baluska, con cui collabora spesso, hanno individuato livelli insolitamente alti di attività elettrica e consumo di ossigeno. In una serie di articoli hanno ipotizzato che questa “zona di transizione possa essere il luogo in cui si trova il “cervello delle radici”, termine proposto per la prima volta da Darwin. Questa tesi non è ancora dimostrata e piuttosto discussa. “Nessuno sa bene cosa succede lì”, mi ha detto Lincoln Taiz, “ma non esistono prove che sia un centro di comando”.
Il modo in cui le piante fanno quello che fanno senza avere un cervello – quella che Anthony Trewavas ha chiamato la loro mindless mastery (competenza senza mente) – solleva molti interrogativi su come funziona il cervello. Quando ho chiesto a Mancuso come funzionava e dove si collocava la memoria delle piante, ha ipotizzato un possibile ruolo dei canali del calcio e di altri meccanismi, ma poi mi ha ricordato che dove e come sono immagazzinati i nostri ricordi è ancora un mistero. “Potrebbe essere lo stesso tipo di meccanismo, e se riusciamo a capire come funziona nelle piante forse riusciremo a comprendere anche come funziona negli esseri umani”. L’ipotesi che il comportamento intelligente delle piante sia una proprietà che emerge dallo scambio di segnali tra cellule all’interno di una rete può sembrare azzardata, ma forse il modo in cui l’intelligenza umana emerge da una rete di neuroni non è molto diverso. La maggior parte dei neuroscienziati riconosce che, anche se il cervello nel suo complesso funziona da centro di comando in quasi tutti gli animali, al suo interno non sembra esserci nessun posto di comando, ma solo una rete. La sensazione che abbiamo a proposito delle piante – che non ci sia nessun mago dietro le quinte a tirare le leve – potrebbe valere anche per il nostro cervello. “Senza dubbio gli esseri umani sono speciali”, dice Mancuso. “Siamo la prima specie in grado di discutere su cos’è l’intelligenza. Ma è la quantità, non la qualità” dell’intelligenza che ci distingue. Ci collochiamo in un continuum con le acacie, i ravanelli e i batteri. “L’intelligenza è una proprietà della vita”, dice.
Applicare il concetto di “memoria” a tutti i regni della natura è ancora più difficile, forse perché sappiamo così poco di come funziona. Tendiamo a pensare ai ricordi come a qualcosa di immateriale, ma nel cervello degli animali alcuni tipi di memoria implicano la formazione di nuove connessioni tra i neuroni. Esistono però anche sistemi per immagazzinare informazioni che non richiedono l’intervento dei neuroni. Le cellule del sistema immunitario “ricordano” l’esperienza di certi agenti patogeni e la tengono presente in seguito. Nelle piante, fattori come lo stress possono alterare lo strato molecolare che avvolge i cromosomi, e questo a sua volta determina quali geni verranno espressi e quali messi a tacere. Questo cosiddetto effetto “epigenetico” può permanere e a volte essere trasmesso alla prole. Più di recente alcuni scienziati hanno scoperto che anche i traumi e le carestie producono nel cervello degli animali cambiamenti epigenetici duraturi che possono essere trasmessi alla prole, una forma di memoria molto simile a quella osservata nelle piante. Parlando con Mancuso, continuavo a pensare a concetti come “volontà”, “scelta” e “intenzione”, che lui sembra attribuire alle piante con grande disinvoltura, quasi come se avessero una coscienza. A un certo punto mi ha raccontato della cuscuta, una pianta parassita che si avvolge intorno allo stelo di un’altra pianta da cui poi succhia il nutrimento. La cuscuta “sceglie” tra varie potenziali ospiti, valutando dall’odore quale può offrirle il nutrimento migliore. Dopo aver scelto la vittima, prima di decidere quante volte dovrà avvolgersi, la cuscuta fa una sorta di calcolo costi-benefici, più sono le sostanze nutrienti della vittima e più giri farà.
Un’idea che spaventa
Forse la parola più inquietante che si possa applicare alle piante è “coscienza”. Se la coscienza è la consapevolezza interiore di vivere un’esperienza – “la sensazione di quello che succede2, per usare le parole del neuroscienziato Antonio Damasio – possiamo affermare senz’altro che le piante non ce l’hanno. Ma se la definiamo più semplicemente come lo stato in cui si è consci del proprio ambiente, allora potremmo dire che le piante sono esseri coscienti, almeno secondo Mancuso e Baluska. “Il fagiolo sa esattamente quello che c’è nell’ambiente che lo circonda”, dice Mancuso. “Non sappiamo come fa. Ma questo è uno dei tratti della coscienza: conoscere la propria posizione nel mondo. Una pietra non ha questa consapevolezza”. A sostegno di questa affermazione, Mancuso e Baluska fanno osservare che si può far perdere la coscienza alle piante con gli stessi anestetici che si usano per gli animali: certi farmaci possono indurre nelle piante uno stato di inerzia simile al sonno. Inoltre, quando sono danneggiate o stressate, producono una sostanza chimica, l’etilene, che funziona da anestetico sugli animali. Quando a Vancouver ho appreso questa cosa incredibile da Baluska, gli ho chiesto cautamente se pensava che le piante potessero provare dolore. “Se le piante sono coscienti, certo, dovrebbero provare dolore”, ha detto. “Se non senti il dolore ignori il pericolo e rischi di non sopravvivere. Il dolore è un tratto adattivo”. Devo essergli apparso allarmato, perché ha aggiunto: “lo so, è un’idea che spaventa. Viviamo in un mondo in cui dobbiamo nutrirci di altri organismi”.
Non ero preparato a prendere in considerazione le implicazioni etiche di un’intelligenza vegetale, e sentivo che la mia resistenza a quella teoria stava aumentando. Cartesio era convinto che solo gli esseri umani avessero coscienza di sé e non riusciva ad accettare l’idea che altri animali potessero provare dolore, quindi liquidava le loro urla e lamenti come semplici riflessi, puro rumore fisiologico privo di significato. Stiamo commettendo lo stesso errore con le piante? Il profumo del gelsomino e del basilico o quello dell’erba appena tagliata, che ci sembra così dolce, è l’equivalente chimico di un urlo? O, Per il semplice fatto di porci questa domanda, stiamo ricadendo nelle tesi poco scientifiche della Vita segreta delle piante?
Quando si parla di sofferenza delle piante Lincoln Taiz si spazientisce, chiedendosi cosa possa produrre questa sensazione in assenza di un cervello. In altre parole: “Niente cervello, niente dolore”. Mancuso è più cauto. Non potremo mai stabilire con certezza se le piante soffrono o se la loro percezione di una ferita è sufficientemente simile a quella di un animale da giustificare l’uso della stessa parola: “Non lo sappiamo, quindi non ne possiamo parlare”. Mancuso è convinto che, dato che le piante sono esseri sensibili e intelligenti, dobbiamo trattarle con un certo rispetto. Questo significa evitare che il loro habitat venga distrutto e astenerci da cose come le manipolazioni genetiche, le monocolture e la creazione di bonsai. Ma questo non ci impedisce di mangiarle. “Le piante sono fatte per essere mangiate, rientra nella loro strategia evolutiva”, dice. E a sostegno della sua tesi cita la loro struttura modulare e la mancanza di organi insostituibili.
A quanto sembra, il problema centrale che divide i neurobiologi vegetali dai loro detrattori è questo: facoltà come l’intelligenza, la percezione del dolore, la capacità di apprendere e la memoria richiedono la presenza di un cervello o sono indipendenti dalla neurobiologia?
La questione è sia filosofica che scientifica, perché tutto dipende da come definiamo questi termini. I sostenitori dell’intelligenza vegetale affermano che la definizione tradizionale è antropocentrica, replicando argutamente all’accusa di antropomorfismo che gli viene spesso rivolta. Il loro tentativo di allargare le definizioni è facilitato dal fatto che il significato di queste parole è piuttosto vago. Al tempo stesso, dato che in origine queste parole sono state create per descrivere certe caratteristiche degli animali, non dovremmo sorprenderci se si adattano male alle piante. Sembra probabile che, se i neurobiologi vegetali fossero disposti a parlare di intelligenza, capacità di apprendere, memoria e coscienza “specifiche delle piante”, questa “disputa scientifica” avrebbe, almeno in parte, fine. In realtà ho scoperto che c’è più consenso sui dati scientifici alla base di questa teoria di quanto mi aspettassi. Perfino Clifford Slayman, il biologo di Yale che ha firmato la lettera del 2007 contro la neurobiologia vegetale, è disposto ad ammettere che le piante sono capaci di “comportamenti intelligenti”, anche se non pensa che le piante abbiano un’intelligenza. Nelle email che ci siamo scambiati, ci ha tenuto a sottolineare la differenza: “Non sappiamo in cosa consiste l’intelligenza, sappiamo solo quello che possiamo osservare e giudicare come comportamento intelligente”. Slayman definisce comportamento intelligente “la capacità di adattarsi al variare delle circostanze”, aggiungendo che “deve essere sempre misurata in relazione a un particolare ambiente”.
Il profumo del gelsomino e del basilico è l’equivalente chimico di un urlo?
Forse gli esseri umani sono intrinsecamente più intelligenti dei gatti, scrive, ma quando un gatto si trova davanti un topo è probabile che il suo comportamento sia più intelligente.
Slayman ammette anche che “è perfettamente possibile che un comportamento intelligente si sviluppi senza un centro nervoso, un quartier generale o un cervello, comunque lo si voglia chiamare. Dovremmo piuttosto pensare a una ‘rete’. Sembra che molti organismi superiori, al loro interno siano collegati in rete in modo tale che certi cambiamenti a livello locale, come quello del gradiente dell’acqua per le radici, provochino reazioni localizzate dalle quali trae vantaggio tutto l’organismo”. Vista così, aggiunge Slayman, la teoria di Mancuso e Baluska è “abbastanza in linea con la mia idea delle reti biochimiche e biologiche”. Anche se è comprensibile che gli esseri umani tendano a privilegiare il modello del “centro nervoso”, spiega, noi abbiamo anche un secondo sistema nervoso automatico che governa i processi digestivi e “per la maggior parte del tempo opera senza ricevere istruzioni dall’alto”. Il cervello è solo uno dei mezzi che la nostra natura usa per portare a termine compiti complessi, per affrontare in modo intelligente le sfide dell’ambiente. Ma non è l’unico. “Sì, anch’io direi che il comportamento intelligente è una delle proprietà della vita”, conclude. “Perché mai a una pianta dovrebbe interessare Mozart?”, rispondeva l’etnobotanico Tim Plowman quando gli chiedevano cosa pensasse delle meraviglie descritte nella Vita segreta delle piante. “E anche se fosse, perché la cosa dovrebbe colpirci tanto ? Non ci basta sapere che mangiano la luce ?”.
Il simbolo della modernità
Un modo per ricordare l’importanza delle piante è dimostrare che hanno capacità simili a quelle degli animali. Un altro è sottolineare tutte le cose che loro sono in grado di fare e noi no. Alcuni scienziati si sono chiesti se l’enfasi “animalocentrica” e l’ossessione per il termine “neurobiologia” non siano un errore e forse anche un insulto per le piante. Come fanno le piante a fare tutte quelle cose straordinarie senza un cervello? Senza muoversi?
Concentrandoci sulla loro diversità piuttosto che sulla loro somiglianza con noi, dice Mancuso, forse potremmo imparare qualcosa di importante e sviluppare nuove tecnologie. Come può l’esempio dell’intelligenza vegetale aiutarci a progettare computer, robot o reti migliori? Quando la maggior parte di noi pensa alle piante, le vede come residui di un passato evolutivo preumano più semplice. Ma per Mancuso le piante sono la chiave di un futuro che sarà organizzato intorno a sistemi e tecnologie in rete, decentrati, modulari, iterativi, ridondanti e verdi, capaci di nutrirsi di luce. “Le piante sono il grande simbolo della modernità”. O comunque dovrebbero esserlo. La loro forza, e forse la più preziosa ispirazione che possiamo trarre da loro, sembra essere proprio la mancanza di un cervello. Durante la cena a Vancouver, Mancuso mi ha detto: “Dopo che ci siamo visti a Firenze, mi è capitato di leggere una frase di Karl Marx a cui non smetto di pensare: ‘Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria’. Ogni volta che costruiamo qualcosa, ci ispiriamo all’architettura del nostro corpo, che ha una struttura solida e un centro. Ma è fragile. Questo significa la frase di Marx. Perciò la mia domanda è: siamo capaci di immaginare qualcosa di completamente diverso, magari ispirandoci alle piante?”.
L’autore
Michael Pollan è un giornalista statunitense. Ha scritto Il dilemma dell’onnivoro ( Adelphi 2008 ). Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è In difesa del cibo (Adelphi 2009).
Articolo tratto da: Internazionale 1042-2014